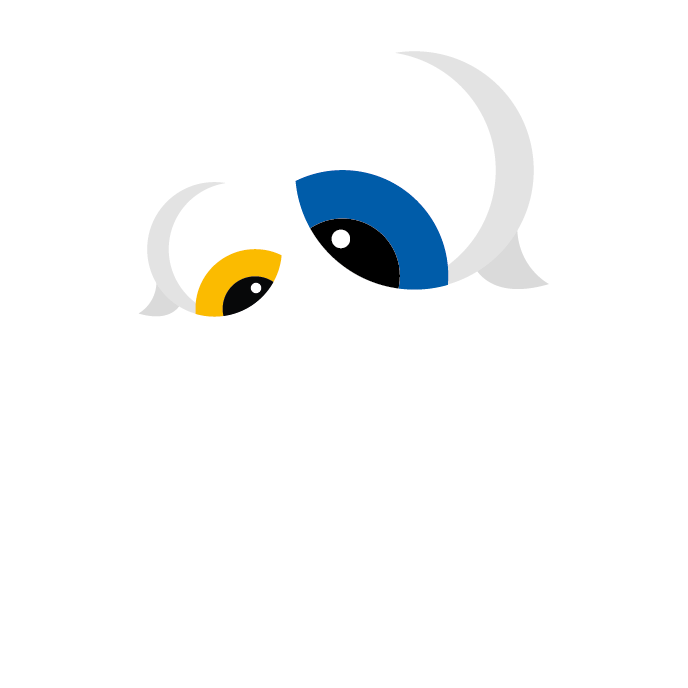Fare del basket una delle proprie ragioni d’essere, ma al tempo stesso lasciare aperta la porta dello studio, quella verso prospettive future, quella dell’approfondimento e della conoscenza. Una strada non semplice, perché lo sport professionistico è fatto di delicati equilibri, impegni costanti, sponsor, aspettative e contratti. E per molti dei suoi protagonisti basta a sé stesso. Ma per Luca Cesana, 26 anni, play/guardia della Pallacanestro Cantù, dottore magistrale in Psicologia, la vita è un insieme di sfaccettature e lo sportivo, anche quello di più alto livello, non può dimenticarsi di essere prima di tutto una persona. Rientrato in partita domenica 17 dicembre dopo una fastidiosa fascite plantare che lo ha tenuto fuori dal campo per due mesi, lo abbiamo intervistato per dialogare di sport, social, gestione delle emozioni e spirito di squadra.
Com’è nato e come si alimentato nel giovane Luca Cesana l’amore per il basket?
Vengo da una famiglia di sportivi, con tre fratelli più grandi di me che hanno sempre giocato a calcio e basket. Io li ho provati entrambi, ma del basket mi sono innamorato. Ricordo ancora quando con la mia famiglia andai a Bormio nell’estate del 2004 ad assistere al ritiro della Nazionale in partenza per i Giochi di Atene, dove poi conquistò uno storico argento. Giocavo con gli amici, il basket mi faceva sentire bene. Sono cresciuto da ragazzino nel vivaio della Pallacanestro Cantù, con cui ho vinto uno scudetto Under20. Una volta diventato professionista, ho poi militato in diverse squadre: Treviglio, Eurobasket Roma, Junior Casale, Piacenza.
Fino al rientro a Cantù, una delle patrie del basket italiano, oggi in A2. Cosa significa per te?
Poter tornare a giocare dove sono cresciuto, a casa, è un’emozione indescrivibile. So cosa significa vestire questa maglia, ne sono onorato, sono gasatissimo, spero semplicemente di poter dare il meglio.
Quando hai capito che il basket poteva essere la tua vita?
Attorno ai 16 anni, non ero più un bambino. Venni convocato per la prima volta per un raduno della Nazionale e capii che la cosa si stava facendo seria. Benché poi sia diventato il mio lavoro, a mio avviso il più bello del mondo, ancora oggi gioco a basket principalmente perché mi diverto.


Eppure, non si tratta di un “senso unico”. Perché nel curriculum puoi vantare un onorevole corso di studi con laurea triennale e magistrale in Psicologia. Perché questa scelta e che valore ha?
Quando ho firmato il primo contrato con Treviglio, nel 2016, avevo appena finito le scuole superiori e non avevo molta voglia di studiare. Vedevo entrare i primi soldini, mi bastava lo sport. È stata mia madre a insistere affinché non abbandonassi lo studio, non mi fece fretta, ma mi spinse a cercare qualcosa che mi potesse interessare. E visto che il mio focus è sempre stata la pallacanestro, mi sono detto: scegliamo un percorso che possa aiutarmi nella vita futura, anche se dovesse aiutarmi a migliorare me stesso dell’uno per cento, perché non provarci… E così ho optato per Psicologia. Sono un grande sostenitore della dual career per gli atleti, sono convinto che sia importante tenere aperte diverse prospettive sulla vita: a un certo punto la carriera sportiva finisce e non è sempre scontato riuscire a rimanere nel proprio ambito, che è spesso l’unica dimensione che si è conosciuta in una vita dedicata allo sport. È invece fondamentale accrescere la propria cultura sotto diversi punti di vista, mantenersi attivi mentalmente.

È stato un percorso complicato?
Inizialmente sì, non riuscivo a trovare il metodo giusto per studiare e ricordarmi quanto avevo letto e ascoltato. Poi ho seguito un percorso che mi ha aiutato a sviluppare un mio metodo di apprendimento e memorizzazione ed è diventato tutto più semplice. Ho recuperato in poco tempo l’anno che avevo perso, mi sono laureato e poi ho deciso di proseguire con la specialistica, in cui ho conseguito la laurea all’inizio di quest’anno.
Su cosa hai concentrato la tesi?
Sul basket ovviamente, in particolare su come giocatori, professionisti e non, gestiscono le emozioni. Ho realizzato oltre duecento interviste a giocatori e giocatrici maggiorenni, ed è emerso che le differenze nella capacità di gestire le emozioni non dipendono tanto dal livello a cui si gioca e dall’esperienza che ci si porta dietro, quanto piuttosto dalla possibilità o meno di seguire un percorso di preparazione mentale dedicato.
Questo dimostra che prendersi cura dell’aspetto psicologico per gli atleti e le atlete è molto importante. Spesso non c’è questa attenzione e gli sportivi faticano a gestire emozioni come la rabbia o le frustrazioni date da una sconfitta o da un periodo di stop per infortunio.
Per avvicinarci al tema al centro del nostro progetto, che rapporto hai con i social media? Hai mai avuto esperienze negative online?
I social li utilizzo, ma non quanto vorrei. Penso che possano essere un valido strumento e un aiuto per trasmettere al mondo esterno l’ideale del giocatore di basket. Noi abbiamo il dovere di incarnare e trasmettere valori importanti e i social possono aiutare. Personalmente non ho mai subito attacchi d’odio online, ma i tifosi di basket sono molto accesi e – soprattutto in caso di sconfitta – gli articoli e i post che riguardano le prestazioni della squadra sono spesso bersaglio di commenti di questo tipo.
E nella vita “reale”? Quella dei palazzetti dello sport?
Nei nostri palazzetti le partite sono seguite da un pubblico misto, c’è la tifoseria da “curva”, ma ci sono anche famiglie con bambini. Purtroppo, mi è capitato di sentire che qualcuno non vuole portare i propri figli a vedere le partite perché sugli spalti si respira violenza, un po’ come nel calcio. Cosa che, al contrario, in uno sport come la pallavolo non succede. Ed è un peccato, perché in realtà il basket è uno sport divertente e molto adatto alle famiglie. A Cantù, ad esempio, c’è sempre grande spettacolo, le coreografie sono molto coinvolgenti. Io invito davvero tutti a provare a venire a vedere una partita.
Perché consiglieresti a un ragazzino o una ragazzina di avvicinarsi al basket?
Prima di tutto perché ti insegna a stare in gruppo e a rispettare i valori della squadra, accettando il tuo ruolo e mettendoti a disposizione del gruppo. E poi perché è uno sport super dinamico, dove può cambiare tutto in un attimo, un po’ come nella vita. Può capitare di essere sotto di tanti punti e tornare in vantaggio nel giro di pochi minuti.
Il basket ti insegna a non darti mai per vinto.
Per chiudere, ti chiediamo di raccontarci una curiosità. Lo scorso anno, con la maglia di Piacenza, hai fatto segnare un record storico: sei stato il primo italiano a segnare 46 punti con 13 triple in una sola partita. Com’è nata questa impresa?
Venivo da un periodo di forma ottima e realizzavo tanto. Ma non sarebbe stato possibile senza l’aiuto dei miei compagni di squadra, che mi hanno messo nelle condizioni di esprimermi al meglio. Giocavamo contro Orzinuovi e dopo tre quarti avevo già segnato 9 canestri da 3. Così, per curiosità, ho chiesto al team manager quale fosse il record in Italia e lui, dopo una breve ricerca, mi disse: 12. Eravamo già sopra di 20 punti, la partita era nelle nostre mani, e così ci siamo concentrati tutti su quel mio obiettivo. Anche i compagni di squadra più individualisti si sono messi a mia disposizione e mi hanno passato la palla ogni volta che potevano, fino a quando, allo scadere, sono riuscito a segnare la tredicesima tripla. Una grande emozione personale, resa possibile da un lavoro di gruppo.