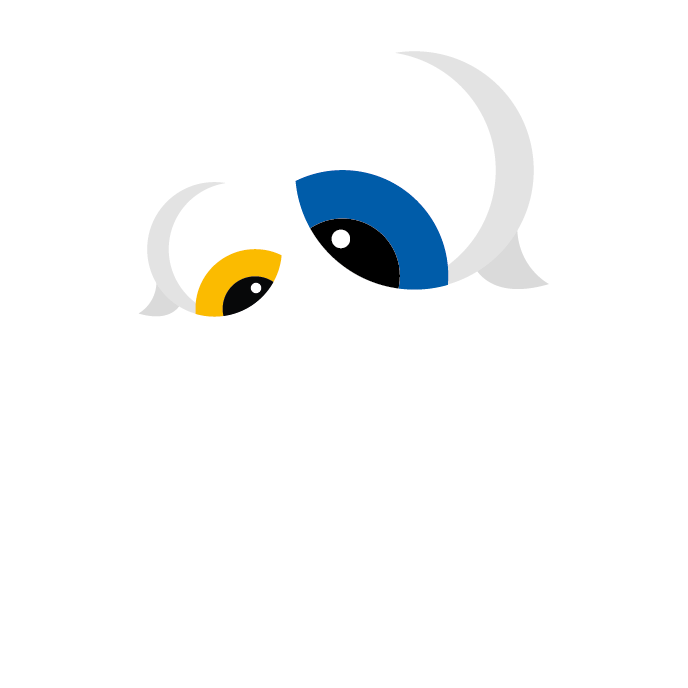Nascere due volte. Ripartire da un’amputazione per tornare a sorridere alla vita, dopo un dolore continuo, capace di rovinare l’infanzia. A 24 anni Emanuele Lambertini è una delle punte della squadra azzurra di scherma paralimpica, impegnato in due delle armi previste dalla disciplina, fioretto e spada, oro Mondiale nel fioretto a squadre, campione mondiale Under23 e plurimedagliato in coppa del Mondo, nonché testimonial della Onlus Art4Sport, fondata dai genitori della campionessa Bebe Vio. Ma le sue vite sono mille, schermidore, futuro ingegnere, musicista e compositore per passione. Ora guarda a Parigi 2024 con la speranza di grandi risultati e noi lo abbiamo intervistato per scoprire la sua storia e il valore dello sport nella sua vita.
di Ilaria Leccardi
Emanuele, fai parte della squadra paralimpica di scherma azzurra, in quanto amputato alla gamba destra. La tua non è la storia di un incidente, ma di una malattia che ti ha fin da subito insegnato a confrontarti con il dolore. Ci racconti la tua esperienza?
Sono nato con rarissima malformazione vascolare alla gamba destra. Inizialmente i medici pensavano che le macchie rosse sulla pelle fossero delle semplici “voglie”. Ma quando ho compiuto un anno, quelle macchie iniziarono a ingrandirsi, ne spuntarono altre, e con loro anche ulcere e abrasioni molto dolorose. Iniziai un’odissea per cercare una cura, tra Italia, Stati Uniti e Francia. Nessuno riusciva a trovare la terapia giusta e, anzi, tante delle strade percorse erano sbagliate. Fui addirittura sottoposto a quattro cicli di chemioterapia. In Francia trovai l’ospedale specializzato in cui meglio riuscivano a seguirmi. Per tre lunghi anni ho vissuto tra la mia casa e Parigi. Fu molto difficile per me, per i miei genitori, le mie sorelle. Quella gamba, sempre gonfia, a rischio emorragie, mi stava divorando il futuro, non potevo giocare, correre, non potevo farmi la doccia in serenità. Fino a quando, nel 2007, i medici francesi mi presero da parte e mi spiegarono che la soluzione migliore era l’amputazione dell’arto e che quello era il momento migliore per procedere, visto che il mio fisico si era stabilizzato. La mia reazione fu positiva, dissi: “So com’è la vita con questa gamba, ed è terribile, voglio provare a vedere com’è senza”. Avevo otto anni.
Com’è ricominciata la vita “senza”?
Venni amputato a Parigi e la mia vita prese una svolta colossale. Certo, il mio fisico si doveva abituare, ho affrontato alcuni mesi di riabilitazione non semplici, ma poi iniziai una vita completamente nuova, con una naturalezza che non potevo neanche immaginare. Mi sono avvicinato allo sport proprio grazie alla riabilitazione, iniziai a praticare il nuoto.

E alla scherma come sei arrivato?
Dopo un anno e mezzo di nuoto, il mio istruttore ha dovuto lasciare la piscina e io non avevo più nessuno che potesse rispondere alle mie esigenze. A Bologna mi rivolsi allo sportello del Comitato Italiano Paralimpico che indirizza giovani con disabilità ai vari centri sportivi. Qui i miei genitori vennero messi in contatto con Gianni Scotti, allora presidente regionale del Comitato Paralimpico Italiano, che propose loro di indirizzarmi alla scherma. Non sapevo nulla di questo sport, ma volevo provare. Entrai alla Zinella Scherma di San Lazzaro di Savena dove iniziai a lavorare con Magda Melandri, maestra che mi segue ancora oggi.
Negli ultimi anni la scherma paralimpica ha fatto grandi passi in termini di seguito e visibilità, anche grazie a una campionessa come Bebe Vio. Percepisci anche tu questa maggiore attenzione?
Sì, la scherma paralimpica è entrata a far parte della Federazione Scherma e questo le ha dato ulteriore visibilità. Stiamo raggiungendo importanti risultati a livello internazionale e poche settimane fa sono stato uno dei 13 componenti della squadra paralimpica (tra cui 4 schermidori, NdR) a prestare giuramento nella Polizia di Stato, un passo molto importante per tutto il movimento.
Tu hai partecipato a due Paralimpiadi, Rio 2016 e Tokyo 2020 (svolta in realtà nel 2021 a causa della pandemia da Covid). Che esperienze sono state?
Un’emozione indescrivibile, soprattutto Rio. Ho scoperto di essere qualificato nel mese di giugno, poco prima dell’inizio dei Giochi, mentre gli altri componenti della spedizione lo sapevano già da alcuni mesi. Poco prima avevamo disputato gli europei individuali e squadre, dove arrivammo secondi per poco. Ma una verifica fece emergere che il punteggio non era corretto e fummo ripescati. Cancellai gli impegni dell’estate e partii con la squadra, ero il più giovane di tutta la spedizione azzurra, con i miei 17 anni. Questo mi ha permesso di vivere l’esperienza sia con gli occhi di un adolescente, sia con occhi più adulti, per la responsabilità di vestire la maglia azzurra. Mio padre, dopo aver visto la cerimonia di apertura in televisione, non è riuscito a rimanere a casa come previsto ed è partito per Rio per venire a seguirmi dal vivo. A Tokyo è stato altrettanto bello, anche se la vita al villaggio olimpico è stata un po’ smorzata a causa del Covid. Se a Rio non avevo pretese di medaglie, a Tokyo invece ci speravo, mi ero allenato tantissimo, ma nell’individuale ho perso di un pelo, sia nella spada che nel fioretto. Ci penso ogni singolo giorno… Ora guardo con grande attesa a Parigi 2024.


La tua vita però non si ferma allo sport…
Porto avanti altre due grandi passioni. La musica, suono il pianoforte ormai da tempo, dopo aver iniziato seguendo l’esempio delle mie sorelle maggiori, e compongo brani originali che spesso diffondo e condivido sui social. E poi lo studio: sto frequentando Ingegneria dell’automazione a Bologna e il mio sogno per il futuro è aiutare altre persone che come me hanno necessità di utilizzare una protesi, uno degli sbocchi possibili del mio percorso universitario. Mi rendo conto che ogni materia che studio e ogni esame che do mi permettono di aggiungere un tassello alla mia strada in questa direzione.
Sui tuoi profili, Instagram in particolare, racconti molto di te. Che rapporto hai con i social?
Li ritengo un importante mezzo di comunicazione, tramite cui sto cercando di divulgare la mia storia, il mio rapporto con la gamba amputata e la protesi, con le sofferenze dell’Emanuele bambino che comunque riusciva a sorridere, per cercare di raccontare come vivo la mia vita: alla leggera, ma non con leggerezza. E quindi metto nella narrazione anche un po’ di ironia.
Non ho problemi a porre me stesso, per come sono, davanti al mondo che mi circonda. E questo cerco di metterlo in pratica anche quando incontro i ragazzi delle scuole o con le aziende durante gli incontri a cui partecipo.
Hai mai vissuto episodi negative a causa dei social?
La maggior parte sono situazioni molto belle: tante persone mi scrivono per dirmi che le ho aiutate, come esempio e stimolo, spesso sono famiglie e ragazzi che stanno vivendo percorsi simili al mio. Solo in un caso anni fa sono incappato in un episodio molto spiacevole, a causa di un mio errore di ingenuità. Dopo una medaglia in Coppa del mondo a Tokyo pubblicai una fotografia in cui sorridevo e mimavo gli occhi a mandorla, non sapendo che il gesto era mal visto e ritenuto offensivo dalle persone asiatiche. Errore mio. Nel giro di poche ore sono stato sommerso da insulti e minacce molto pesanti provenienti un po’ da tutto il mondo. È stato un momento difficile e mi ha fatto capire prima di tutto che bisogna essere sempre consapevoli di quello che si fa, e io in quel caso ero stato davvero ingenuo e me ne scuso, lo feci anche pubblicamente, ma anche che i social possono essere un motore di odio molto forte, di messaggi che rimbalzano e si amplificano, spesso senza lasciare spazio al confronto o alla spiegazione.
Però sei anche quello che celebra il 25 aprile davanti ai memoriali dei partigiani e che non si risparmia quando si tratta di portare aiuti in prima persona, come nel caso delle recenti alluvioni in Emilia Romagna…
Diciamo che sono una persona molto eclettica e tutto quello che faccio lo inserisco nel mio percorso di vita come una crescita individuale e collettiva. Per questo, anche forte della mia esperienza da scout vissuta da ragazzino, appena finita una serie di gare a giugno ho deciso che sarei partito per fare la mia parte e aiutare famiglie e persone le cui case erano state sommerse dal fango. Mi sono organizzato, informandomi nei centri di dislocamento volontari, e sono partito più volte, o con persone del mio paese o da solo. È stata un’esperienza indescrivibile. Sono convinto che davanti alle difficoltà ciascuno debba dare il proprio contributo.

Quello che ti aspetta è un autunno impegnativo. A breve sarai protagonista di nuovi appuntamenti di avvicinamento a Parigi 2024, ma cosa rappresenta per te lo sport nella quotidianità?
Per me lo sport è importante perché sa insegnare che cos’è la sofferenza. Detta così può sembrare strana come affermazione, ma la dice un ragazzo che fin da bambino ha dovuto confrontarsi con il dolore. Ora, da atleta, so che l’unico modo per crescere davvero è allenarmi fino a quando i muscoli mi fanno male per la fatica, spostare i miei limiti di volta in volta un po’ più in là. Gli obiettivi li raggiungi solo se sei disposto ad accettare e sopportare quel dolore e quella fatica. Se devo poi dire qualcosa in particolare della scherma… è una disciplina sportiva che ti dà delle scariche di adrenalina uniche: duelli con un avversario che spesso non conosci, devi avere un grande controllo su di te, è tecnica e strategia. In pedana ci vai da solo, ma per fortuna sai che dietro ha un grande team che ti sostiene e questo per me è fondamentale.