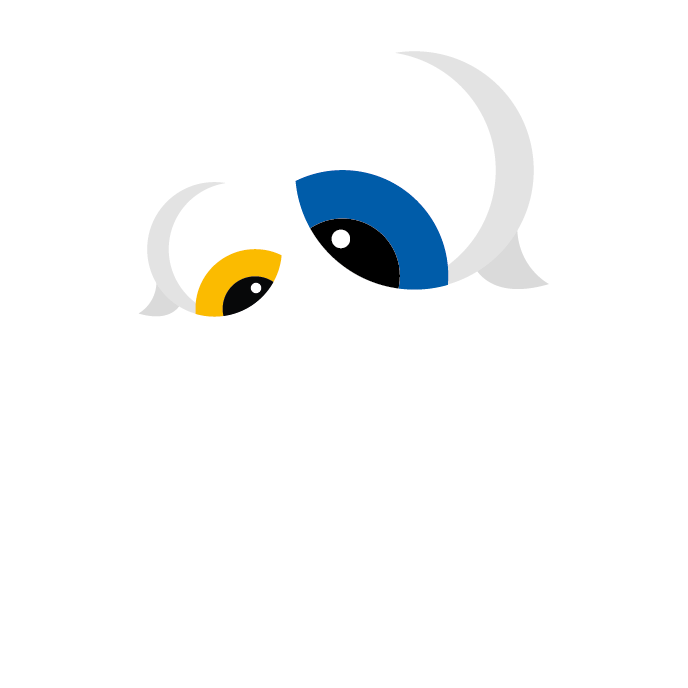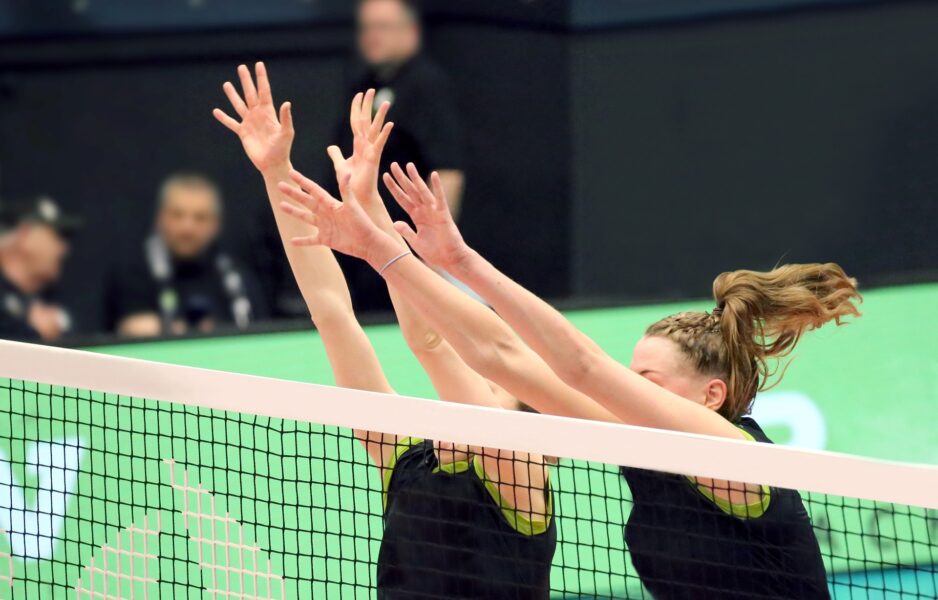L’Italia è un Paese per sportive? Dovrebbe essere scontato dire di sì nel 2021, ma purtroppo ancora troppo grande è il divario tra uomini e donne in tutti gli ambiti dello sport italiano. Se il numero di atleti maschi è maggiore, con una differenza che tuttavia si sta assottigliando, il gap è soprattutto nei ruoli dirigenziali e nel trattamento che alle atlete viene riservato dal mondo sportivo rispetto ai colleghi uomini. Compensi ridicoli, montepremi inferiori, assegnazione delle strutture sportive non sempre paritaria, per non parlare della narrazione che ancora oggi evidenzia la difficoltà di raccontare in modo corretto e con i termini giusti l’universo sportivo femminile.
Eppure negli ultimi decenni tanti passi sono stati compiuti. Ed è soprattutto grazie a chi si è battuta perché qualcosa cambiasse. Luisa Rizzitelli è una pallavolista (mai dire “è stata”, perché non si smette mai di essere sportive) che ha giocato come professionista per 14 anni, diventando testimone sulla propria pelle di tutte le discriminazioni che si potevano vivere sul campo e fuori. E ha deciso che non poteva rimanere in silenzio. E così, nel marzo del 2000, assieme a un gruppo di amiche e colleghe, ha fondato Assist – Associazione Nazionale Atlete, che da allora si è battuta in tutti gli ambiti e i livelli sportivi per ribaltare una situazione inaccettabile. Oggi Assist è una realtà consolidata, interpellata nei più importanti tavoli di lavoro a livello nazionale, ed è stata promotrice nelle ultime settimane di una grande novità, la Carta dei valori per lo sport femminile, approvata dal Comune di Bologna. Un documento importante, volto a dettare le linee guida fondamentali per rendere lo sport veramente paritario.
Rizzitelli, iniziamo proprio da qui. Qual è il valore dei 14 articoli contenuti nella Carta firmata dal Comune di Bologna?
Da tempo avevamo in mente di stilare una Carta che potesse dare indicazioni pratiche alle istituzioni e alle amministrazioni, per come non diventare complici inconsapevoli di alcune discriminazioni. Abbiamo dunque pensato di mettere nero su bianco le azioni che un Comune dovrebbe mettere in pratica e gli aspetti a cui dovrebbe fare attenzione. Per me si tratta di un piccolo atto d’amore nei confronti dell’articolo 3 della Costituzione, secondo il quale nessuno deve essere discriminato.
Cosa prevede la Carta sul piano pratico?

Mette in campo diversi strumenti per affermare la parità di genere e per arrivare a concretizzare il compito di trattare nella stessa maniera le Associazioni sportive che sono attive in ambito femminile rispetto a quelle che lavorano in ambito maschile. Il Comune si impegna a dotarsi di un sistema di rilevazione dati sulla partecipazione femminile alla pratica sportiva in città (Art. 5). Inoltre, si impegna a redigere bandi per la concessione di contributi e l’assegnazione d’uso di impianti sportivi, avendo cura di valutare, nell’attribuzione del punteggio, anche l’esperienza del soggetto richiedente in tema di antidiscriminazione e attenzione al genere e quindi le azioni concrete messe in pratica dalle singole realtà in questa direzione (Art. 9). Sappiamo che ancora oggi spesso le donne, nella scala di utilizzo degli impianti sportivi, sono le ultime a essere tenute in considerazione. Ne è un esempio il calcio, dove, nell’assegnazione degli stadi e dei campi, le squadre di Serie A femminili vengono messe dopo i pulcini di una qualsiasi squadra maschile… E ancora, il Comune si impegna a non concedere contributi economici o patrocini a organizzatori di eventi privati o pubblici che non abbiano pari condizioni di accesso e montepremi uguali per uomini e donne (Art. 10). Non ci siamo inventate nulla, sono principi semplici, ma concreti, per riuscire a incidere realmente su un tessuto sociale.
Tessuto che comunque si è rivelato molto ricettivo…
Sì, Bologna è una città che da questo punto di vista è molto sensibile. È una delle città dove Assist ha più socie e la cui amministrazione si è rivelata molto interessata e pronta a lavorare con noi. Devo ringraziare per questo l’assessora Susanna Zaccaria [con deleghe a Educazione, Scuola, Pari opportunità e differenze di genere, ndr] e l’assessore allo Sport Matteo Lepore. Abbiamo trovato da subito grande disponibilità e intuizione. L’amministrazione ha individuato nella Carta uno strumento importante da condividere con tutte le Asd della Città Metropolitana.
Ci sono altri Comuni pronti a recepirla sul territorio?
Abbiamo avuto interessamenti dalla città di Trento e da alcune città della Calabria. Stiamo cercando di promuoverla a Roma, a Milano, Torino. Speriamo che siano in tanti ad aderire.
Ma in generale, quanto è ancora discriminante verso le donne il mondo dello sport?
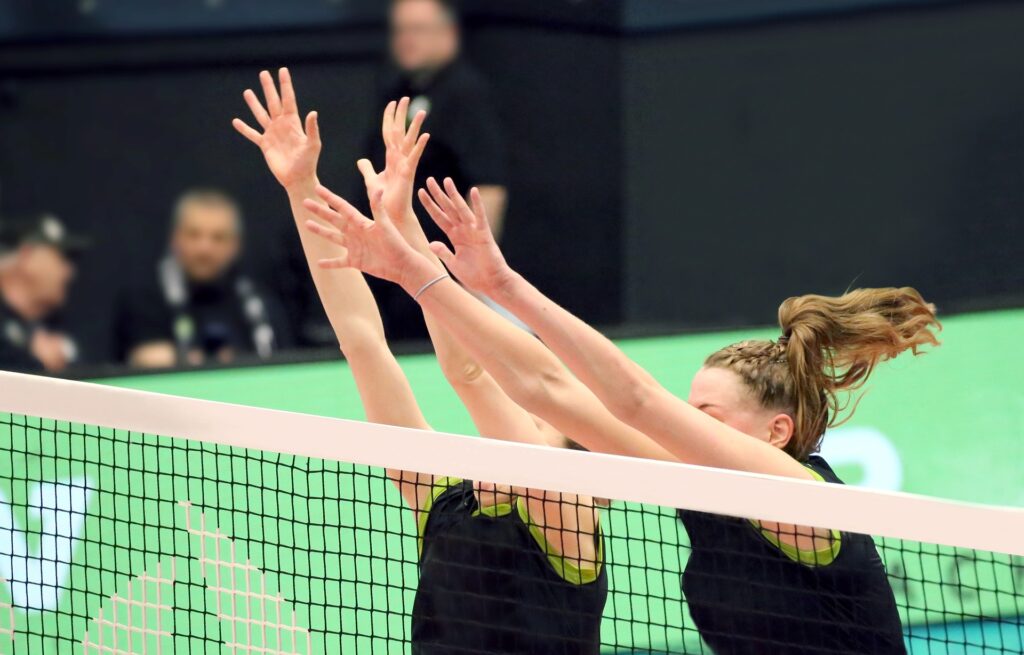
Purtroppo molto, a livello micro e ai livelli più alti. E questo anche perché è un mondo ancora quasi completamente gestito e diretto da uomini, oltretutto uomini di una certa età. Il ricambio giovanile e di genere nello sport non è ancora avvenuto. Anche se nella vita quotidiana sportiva tra atleti e atlete non si percepisce molta differenza di genere, nella gestione dei fondi e degli spazi, emerge ancora una cultura fortemente patriarcale che penalizza le donne. Ci sono ancora divari di investimenti, differenze di premi, borse di studio, montepremi. Noi da anni ci battiamo affinché i podi di una disciplina in ambito maschile e femminile vengano trattati nella stessa maniera.
Per quel che riguarda la pratica sportiva, i problemi sono differenti?
Diciamo che, se tra atleti e atlete le differenze si sentono poco, tuttavia ci sono ancora alcune dinamiche da scardinare. Come Assist abbiamo lanciato un progetto europeo dal titolo Fair Coaching, mirato ad abbattere i comportamenti machisti e impropri che ancora ci sono nella cultura dell’allenare. Il mito che l’allenatore duro e cattivo sia bravo è una stupidaggine.
Essere autorevole non vuol dire essere autoritario, per questo bisognerebbe lavorare maggiormente per un cambio culturale importante, che metta in risalto altri aspetti al fianco della bravura tecnica, per esempio l’empatia e l’attenzione alla dimensione psicologica dell’atleta.
Per tornare al cambio di prospettiva soprattutto in ambito dirigenziale. Assist negli ultimi mesi è scesa in prima linea per sostenere la candidatura di Antonella Bellutti alla presidenza del CONI. Due volte oro olimpico nel ciclismo su pista e ma anche olimpica di bob, è la prima donna a tentare la scalata al vertice dello sport azzurro. Cosa rappresenta questo percorso?
La candidatura di Antonella Bellutti si sta rivelando un percorso entusiasmante. Lei è una persona coraggiosa, che non ha nessuna resistenza o preoccupazione nel dire ciò che pensa. E la sua proposta va nella stessa direzione in cui da ventuno anni Assist lavora. Per noi è straordinario vedere che una donna del suo calibro, Commendatrice della Repubblica, stimata in tutto il mondo per il suo valore, porta avanti da candidata presidente del CONI tutti quei temi su cui noi come Associazione atlete abbiamo puntato da anni in assoluta solitudine. Abbiamo dovuto combattere, per tanto tempo nessuno ci ha dato credito, abbiamo affrontato l’ostruzionismo, siamo state ridicolizzate. E vedere che oggi i nostri temi sono gli stessi del programma della candidata alla presidenza del CONI è importante.
Tuttavia, alle elezioni in programma il prossimo 13 maggio, non sarà semplice vedersela con il presidente uscente Giovanni Malagò. Quali sono i riscontri che avete rilevato per ora?
Abbiamo ricevuto tantissimi contatti da responsabili di Asd, tecnici, atleti, che chiedono di partecipare al percorso che Antonella sta conducendo. Diciamo che la partecipazione è fortissima. Io credo tuttavia che i grandi elettori (74 in tutto, tra cui 44 presidenti federali tutti uomini! ndr), non saranno chiamati a fare una scelta tra due persone, Bellutti e Malagò, tra le quali c’è una grande stima reciproca, ma tra due modi diversi di gestire lo sport italiano e immaginare il suo futuro.
L’ultimo anno è stato importante per il mondo istituzionale sportivo, principalmente per il dibattito sulla Riforma dello sport. Assist è stata anche protagonista nei lavori delle commissioni parlamentari. Una Riforma – ancora da approvare – che ha toccato vari aspetti, ma che ancora non vi soddisfa. Perché?
La nostra critica va soprattutto nella direzione del mancato riconoscimento dei diritti elementari a chi fa dello sport il proprio lavoro. La Riforma aggiunge delle tipologie di inquadramento lavorativo, autonomo, subordinato, occasionale, ma questo non cambia nulla, perché viene lasciata al datore di lavoro la decisione su come inquadrare l’atleta. È stato un timido tentativo, ma per noi del tutto insufficiente. Pensiamo invece che sia necessario partire dal fatto che il lavoro sportivo esiste, ha una sua dignità e non può subire discriminazioni. Di certo però è necessario che venga dato sostegno alle Asd nel complesso passaggio dell’emersione del lavoro professionistico. Le Associazioni sportive non possono essere lasciate sole. E a chi chiede: dove trovare i soldi? Be’, ad esempio, noi sosteniamo che si debba ridimensionare il ruolo dato ai gruppi sportivi militari, un’anomalia tutta italiana che costa allo Stato 36 milioni di euro. E troppe volte per gli sportivi e le sportive questa è l’unica possibilità per mantenersi, ma ricordiamo che non tutte e tutti debbano volere per forza vestire una divisa. Quei fondi potrebbero invece essere investiti a sostegno delle Asd, dei centri universitari sportivi, dei vivai.
Ci sono stati negli ultimi anni esempi particolarmente positivi in ambito sportivo che vanno nella direzione della parità di genere?
Per lo più iniziative individuali. L’ultima in ordine di tempo è stata la decisione della squadra di ciclismo Trek Segafredo che ha introdotto il minimo salariale per le donne, pari a quello degli uomini. La FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) ha compiuto un grande lavoro per eguagliare i montepremi delle gare di donne e uomini. Da anni possiamo inoltre testimoniare che la Lega Volley Femminile sta cercando di strutturare al meglio possibile le questioni riguardanti i diritti delle atlete. Ma il caso di Carli Lloyd, palleggiatrice della Vbc Casalmaggiore, costretta a rescindere il contratto dopo aver scoperto di essere incinta, ci riporta alla triste realtà. Ci sono contesti sportivi e realtà dove si tenta fare qualche passo in più, ma se questo viene affidato solo a chi rappresenta i datori di lavoro, ossia le società sportive, è ovvio che verrà fatto il loro interesse. Per quel che riguarda nello specifico il diritto a diventare madri, lo Stato ha creato un fondo maternità per le sportive. Una novità positiva, ma si tratta comunque di un palliativo.
Altro aspetto molto delicato in ambito sportivo sono gli episodi di discriminazioni e abusi. Assist come si è mossa in questi anni?

Abbiamo lanciato campagne contro il linguaggio sessista e lesbofobico, ancora molto diffuso purtroppo. Siamo state inserite nel tavolo antidiscriminazioni dell’Unar, con la stessa dignità delle Federazioni nazionali, e questo ci fa grande onore. E poi, come ultima iniziativa, volta in particolare a contrastare il fenomeno degli abusi e delle molestie, abbiamo lanciato SAVE, acronimo di Sport Abuse and Violence Elimination. Si tratta di un servizio nato in collaborazione con la ong Differenza Donna, da anni attiva nel contrasto alla violenza di genere e gestore del numero verde antiviolenza 1522 del dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio, con cui conduciamo una campagna di sensibilizzazione e forniamo supporto concreto alle ragazze e alle donne che potrebbero essere vittime di abusi. A partire da questa esperienza, la Regione Lazio ha voluto lanciare una campagna contro gli abusi e le molestie nello sport che prenderà via a marzo 2021, toccando Asd e scuole.
A ventuno anni ormai dalla nascita di Assist, se si guarda indietro cosa vede?
Vedo ancora ciò che mi ha spinto a fondare questa realtà, l’amore infinito che ho per lo sport e per la giustizia. Io sono stata un’atleta professionista nella pallavolo, ho vissuto le stesse cose per cui combatto adesso. Ho dato il via a questa realtà con un gruppo di amiche meravigliose con cui lavoro ancora, a cui poi si sono unite lungo la strada molte altre persone. Vedo ancora discriminazioni in un mondo che amo immensamente. E continuerò a battermi, perché ricordo le lacrime mie e delle mie compagne, quando quelle discriminazioni le subivamo, quando venivamo vendute con il nostro cartellino, come se fossimo al mercato delle vacche. E vorrei un mondo diverso per le ragazze di domani.