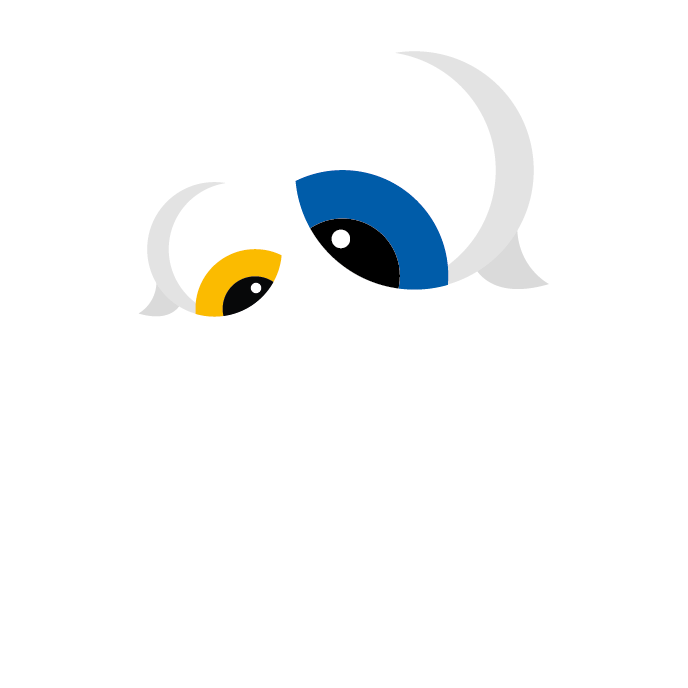“La boxe mi ha insegnato a guardare negli occhi la persona che ho davanti. Quando ero piccola camminavo sempre a testa bassa. E una delle prime cose che il mio allenatore mi ha detto quando ho iniziato a muovermi sul ring è stato proprio questo: alza la testa, guarda in faccia il tuo avversario. Un insegnamento importante che mi è stato molto utile anche nella vita e sul lavoro. Se guardi negli occhi il paziente, il rapporto cambia, sente davvero che lo stai prendendo in carico, che ti stai occupando della sua persona”.
Pamela Malvina Noutcho Sawa ha 32 anni, gli occhi profondi, e una grande passione nel raccontare la sua quotidianità, vissuta tra le corsie dell’Ospedale Maggiore di Bologna, dove è infermiera al pronto soccorso, e le mura della Bolognina Boxe, palestra popolare che è la sua seconda casa da alcuni anni ormai, e dove si allena seguita da Alessandro Danè. Solo poche settimane fa, il 25 ottobre, è salita sul tetto d’Europa, vincendo il titolo continentale pesi leggeri, battendo la pugile serba Nina Pavlovic, in un match che si è svolto a porte chiuse all’Unipol Arena di Casalecchio, a causa dell’emergenza alluvione.

Photo Massimo Gennari

Photo Massimo Gennari
Un titolo per cui ha lavorato tanto, vinto grazie a un match “duro” di cui si dice “molto orgogliosa”. “Di solito – spiega – affronto avversarie che non fanno male, invece la serba, per dirla nel gergo della boxe, è una pugile pesante con le mani. Ho dovuto costruire i punti round dopo round”. Un titolo talmente significativo da suscitare una dedica collettiva e molteplice: alla sua città ferita dall’inondazione, ai lavoratori della Toyota, dopo la morte di due operai a causa di un’esplosione nello stabilimento di Borgo Panigale, a due colleghi infermieri morti suicidi nel corso dell’ultimo anno e a Vincent Plicchi, 23enne che nel 2023 si è tolto la vita, vittima del cyberbullismo. “Conosciamo il papà, è una storia che ci ha toccati molto”.
Come raccontano le parole e le scelte della pugile azzurra, la boxe non esiste senza dimensione sociale. “Da piccola praticavo atletica, quando ancora vivevo a Perugia. Poi sono arrivata a Bologna per gli studi universitari e, durante la magistrale, ho svolto un tirocinio in un centro per persone senza fissa dimora. Lì era attiva una palestra, dove si praticavano varie discipline, ho provato la boxe e mi si è aperto un mondo”. Era il 2014, l’allenatore notò subito la sua predisposizione per il ring anche se inizialmente lei non si dava degli obiettivi sportivi. “Volevo solo tenermi in forma”. Invece, dieci anni dopo, è arrivata ai vertici internazionali. “Questo sport mi ha insegnato a essere ambiziosa. Per carattere mi sono sempre detta: se riesco a fare una cosa, bene; se non riesco, pazienza. Nella boxe è diverso. Devi avere fame, devi allenarti duramente, darti obiettivi anche piccoli da raggiungere. E quando salgo sul ring tutti mi dicono che riesco a tirare fuori la grinta che ho sempre tenuto nascosta”.
Quella della pugile di origine camerunense è una storia di crescita sportiva, ma anche e soprattutto umana e collettiva, vissuta nella famiglia della Bolognina Boxe, una realtà che oggi conta oltre 400 iscritti tra cui molte donne e un nutrito gruppo di bimbe giovanissime. “La nostra è una palestra popolare, dove lavoriamo per affermare determinati valori: antifascismo, nessuna discriminazione, antisessismo. Non esiste per esempio si dica: io non ‘faccio i guanti’ con quella perché è una donna. Si cerca di rispettare tutti, da ogni punto di vista. Anche se non è semplice. Tra le nostre mura si allenano persone di oltre trenta nazionalità diverse e provenienti da qualsiasi situazione, dal poliziotto all’ex carcerato, dal banchiere alla studentessa. Se sentiamo – ad esempio – commenti sessisti o razzisti, andiamo a parlare con chi li ha pronunciati, preferiamo il confronto, il dialogo, cercando di far passare un messaggio di rispetto”.
Che poi dovrebbe essere l’obiettivo di ogni pratica sportiva. “Nello sport – prosegue – non deve esserci odio. A volte penso a quanto sarebbe bello poter far sì che i confronti tra potenze mondiali si svolgessero sui campi sportivi invece che facendo le guerre. Lo sport ha il grande potenziale di far emergere il meglio da ciascuno di noi. Sicuramente in chi lo pratica, ma anche in chi lo guarda e lo segue per passione”.

Photo Massimo Gennari

Eppure, anche lo sport non è esente dall’odio, così come dalle polemiche. Restando sulla boxe, lo ha dimostrato durante i Giochi di Parigi 2024 il caso della pugile algerina Imane Khelif e dell’incontro vinto contro l’azzurra Angela Carini che si è ritirata a pochi minuti dall’inizio del match. “È stata una vicenda che mi ha molto rattristata. Nella boxe siamo abituate a cadere, rialzarci e riprendere. Conosco entrambe le sportive coinvolte, sono due atlete molto brave, ma questo è passato completamente in secondo piano, rispetto a una vicenda più grande di loro. Mi dispiace per Angela che stimo molto come pugile, ma che probabilmente si è trovata in una situazione difficile da sostenere. I miei complimenti vanno a Imane per la capacità che ha avuto di andare avanti a testa alta”.
Ma anche la stessa Pamela Malvina ha vissuto il peso dell’hate speech online, non tanto attorno alla sua carriera sportiva, quanto rispetto al tema della cittadinanza italiana, ottenuta finalmente nel 2022 dopo un lungo iter burocratico. “Sulle mie pagine social è difficile che riceva commenti d’odio, cosa che è invece è successa a seguito di articoli che parlano di me su altre pagine. Quando ho fatto un video sul tema della cittadinanza, ne sono scaturiti commenti terribili, razzisti. In generale, i miei allenatori e lo staff della Bolognina Boxe mi dicono di non leggere i commenti agli articoli perché altrimenti, sostengono, la mia felicità passa in secondo piano. I social sono un contesto molto delicato. Non so nemmeno se le persone che scrivono si rendano conto del peso delle proprie azioni, ma ogni volta che si legge un insulto è come se una ferita si riaprisse. E non tutti hanno la forza per sostenere questo dolore”.
Quello che la pugile azzurra e la sua società sportiva fanno ogni giorno è cercare di costruire percorsi diversi, concreti, inclusivi, di reale confronto, a partire dal ring.