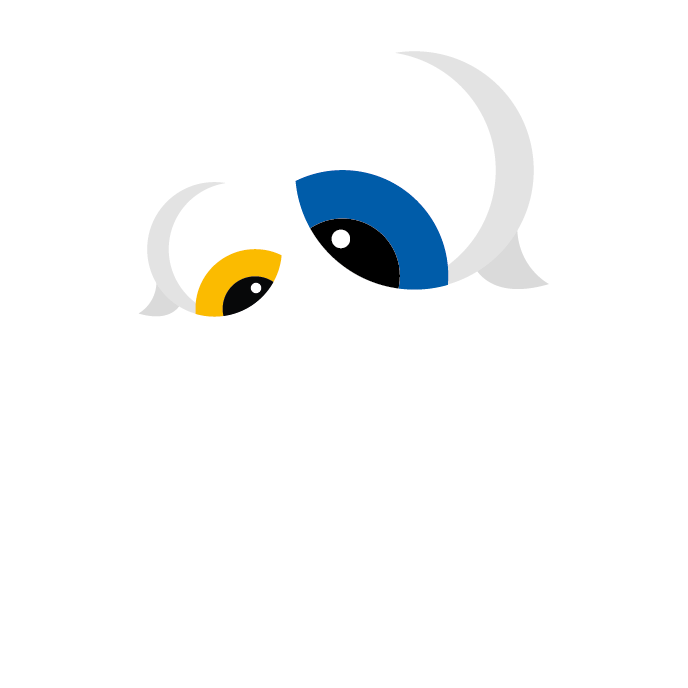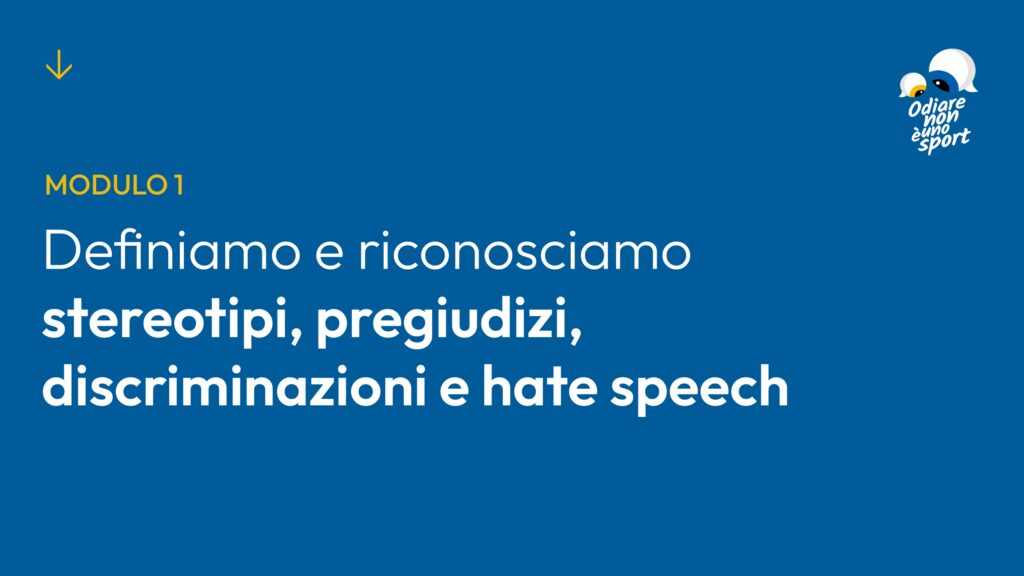Una vita giovane, tanti sport provati, almeno un’esperienza molto negativa di odio vissuto e subito in palestra, che ha portato all’abbandono dell’attività sportiva, determinando disturbi alimentari. Oggi l’utilizzo dei social per raccontare, dialogare su temi delicati, offrire uno spazio di connessione e condivisione. Lei è Sara Bartolini, ha 22 anni e per Odiare non è uno sport ci ha raccontato la sua esperienza con il profilo Instagram ScorciDiSara.
di Gaia Del Bosco (COMI ong)
Sara, raccontaci qualcosa di te.
Ho 22 anni e l’obiettivo della mia vita è trovare l’armonia tra i diversi ingredienti della mia persona. Studio, esco, lavoricchio, mi alleno, ballo, animo…il tutto quanto basta.
Come nasce ScorciDiSara e perché?
È un profilo che ho aperto un paio di anni fa, parallelo al mio personale. Inizialmente l’ho immaginato per condividere scorci della mia vita, in particolare i miei allenamenti e le mie preparazioni in cucina. Volevo farlo in uno spazio dedicato, per non costringere chi mi segue sul mio profilo personale a “sorbirsi” questo tipo di contenuti. Post dopo post, e storia dopo storia, i contenuti hanno iniziato a variare dal solito “cosa mangio” o “come mi alleno” a “ho letto questo libro e volevo parlarvene”, “oggi con la mia nutrizionista abbiamo parlato di questo argomento e voglio condividerlo”, “oggi è la giornata nazionale per la sensibilizzazione ai DCA, parliamone” e così via. Sono temi importanti, su cui penso che i social possano aiutarci a sensibilizzare. Ho fatto un tentativo anche su TikTok, ma poi ho abbandonato, perché è un social più complesso, che necessita di tanta costanza nelle pubblicazioni.



Nella tua storia di giovane ragazza ti porti il peso di un’esperienza sportiva che ha segnato negativamente la tua adolescenza. Ce ne vuoi parlare?
Nei miei 22 anni ho cambiato almeno sei sport, anche perché per andare avanti bisognava eccellere, o almeno questo è quello che volevano farmi credere gli allenatori. Il caso più eclatante è stato nella pallavolo: ho iniziato a giocare in terza media, in un periodo delicato della vita di tutti, l’inizio dell’adolescenza, dove la terapia mi ha poi svelato lo stabilirsi delle radici del mio disturbo alimentare. Per i primi due anni di pallavolo, l’allenamento è stato un ambiente confortevole: compagne divertenti, allenatrice appassionata e gentile, poco agonismo e tanta spensieratezza. Poi all’improvviso tutto è cambiato… All’inizio del terzo anno (seconda superiore per me) ci venne comunicato che alcune di noi, teoricamente le più talentuose, avrebbero formato una squadra di elite per partecipare a un campionato di livello più alto. Dopo qualche mese, anche io venni chiamata a prendere parte alla nuova squadra, il che significava più allenamenti, più partite, ma soprattutto compagne e allenatori diversi. L’invito a questo “scatto di carriera” mi ha fatto sentire apprezzata e, nonostante qualche dubbio da parte dei miei genitori dato il maggiore impegno richiesto (al tempo erano loro che mi accompagnavano ad allenamenti e partite), ho accettato: la mia più grande sliding door.
Cosa è successo?
Qualcosa è andato storto… Non ero un talento nato e questo costituiva un intralcio per la missione del mio allenatore: trovare in ognuna di noi la nuova Paola Egonu. La sua ricerca disperata lo portava a usare un’arma letale, proprio quella dell’hate speech e delle punizioni fisiche in seguito agli errori. Chi ha fatto pallavolo conosce il trauma dei tuffi: lanci del corpo verso terra che sono spesso utilizzati come punizione dopo un errore in allenamento.
Quell’uomo, le sue parole e il suo trattamento mi hanno portata a odiare lui, ma soprattutto a odiare me stessa. Ho creduto che le mia capacità nella pallavolo fossero la misura del mio valore nella vita. Questo mi ha portata a una profonda auto-svalutazione e hanno creato il terreno fertile che le radici del mio disturbo alimentare andavano cercando. Ho abbandonato quella situazione appena ho realizzato quanti danni stava causando nella mia vita, le cui cicatrici oggi, quasi dieci anni dopo, sono ancora lì.

L’odio ha diverse forme e, contrariamente a come spesso si pensa, può venire proprio dagli allenatori e dalle figure di riferimento. Credi che sia un problema di “persone” o di “sistema”? Cioè, è una sfortuna incontrare allenatori e allenatrici poco sensibili, o fa parte del “sistema sport”?
È un problema di persone sbagliate nel sistema sbagliato. Ritengo che chi si comporta in questo modo lo faccia per propria natura e non perché condizionato dal sistema, ma è il sistema a legittimare queste azioni. Nel nostro secolo non è una novità che rivolgersi con parole d’odio o imporre una punizione fisica agli atleti sia sbagliato, ma nel mondo dello sport è ancora giustificato dall’idea che possa essere formativo. È proprio da qui che nasce la rilevanza della vostra iniziativa, con la speranza che questi sforzi portino a una disconferma di credenze ormai superate, e alla standardizzazione di nuovi metodi di relazionarsi, più umani.
Sui social ci sono moltissimi profili che si propongono come healthy. Quanti di questi lo sono realmente secondo te?
Il mondo dei profili healthy, com’è facile immaginare, è un’arma a doppio taglio. Il cuore del problema risiede nel fatto che in ambito alimentare tutto è giusto e tutto è sbagliato, sta alla singola persona capire come prendere quell’informazione e cosa farne. Il più classico degli esempi: i video “cosa mangio in un giorno”. Questi dividono l’audience tra chi è profondamente contrario e chi li ama, ma, come per tutte le cose, la verità sta nel mezzo. Il video in cui si mostra ciò che si mangia non ha nulla di intrinsecamente sbagliato: non vuole imporre a nessuno cosa mangiare, non vuole ispirare confronti riguardo le porzioni, non vuole recapitare il messaggio del tipo “se mangi così sarai come me” (tipiche accuse che vengono mosse contro questo format). Ciò che si mostra nel video è un dato oggettivo, che ognuno, sulla base delle proprie credenze personali, elabora in un determinato modo. Per me, Sara Bartolini, questi video sono una fonte di ispirazione per piatti nuovi da preparare, o sfamano la curiosità di scoprire cosa mangiano le persone dall’altra parte nel mondo. Tuttavia per un’altra persona con una consapevolezza e un vissuto diverso dal mio possono essere motivo di sofferenza. Ad esempio, per un’adolescente convinta di mangiare troppo e che pensa che tutti mangino meno di lei, vedere sui social un contenuto del genere potrebbe alimentare questa credenza.
I profili healty non sono dannosi di per sé, ma veicolano messaggi che se recapitati a un o una utente vulnerabile possono creare danni. Forse la soluzione potrebbe essere l’uso di un disclaimer in cui si spiega la neutralità del contenuto, con l’obiettivo di smorzare il potenziale tossico.
Cosa potresti consigliare a chi dovesse trovarsi in una situazione come quella che hai vissuto tu con il tuo allenatore?
Consiglio di sfogarsi innanzitutto con i compagni e le compagne di allenamento, ci sarà chi potrà capirvi meglio perché probabilmente subisce ciò che subite voi. L’importante è capire che quelle parole non hanno fondamento, non dovete dare loro il potere di danneggiarvi. E per concludere: guardatevi attorno e nel caso cambiate squadra o palestra… sicuramente ci sarà uno spazio dove potrete apprezzare voi stessi e le vostre capacità, senza dover rendere conto a qualcuno che tenta di abbattervi.